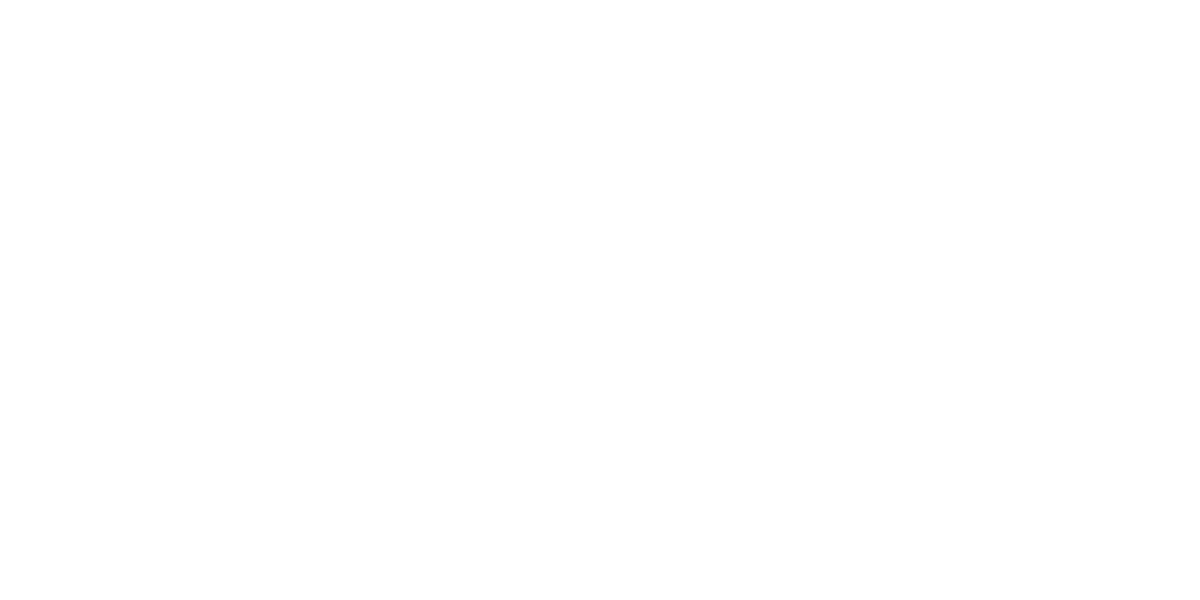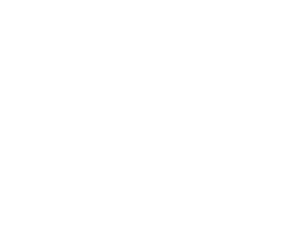L’opuscolo è il 18esimo della serie pubblicata dall’Associazione Italiana per la Libertà della Cultura, che si era costituita sotto gli auspici del Congresso Internazionale per la Libertà della Cultura, e si era data, per scopo, quello di “diffondere i principi definiti in un Manifesto agli intellettuali pubblicato a Roma il 1 dicembre 1951. Principi così formulati:
“Noi riteniamo che il mondo moderno possa proseguire nel suo avanzamento solamente in virtù di quel principio di libertà della coscienza, del pensiero, dell’espressione, che si è faticosamente conquistato nei passati secoli.
Riteniamo che, in quanto uomini e cittadini, anche coloro che professano le arti e le scienze siano tenuti ad impegnarsi nella vita politica e civile, ma che al di fuori delle tendenze e degli ideali politici e delle preferenze per l’una o per l’altra forma di ordinamento sociale e di struttura economica, sia loro dovere custodire e difendere la propria indipendenza, e che gravissime e senza perdono sia la loro responsabilità ove rinuncino a questa difesa.
E riteniamo inoltre che, nell’attuale periodo storico che ha visto e vede tanti sistematici attentati alla vita dell’arte e del pensiero da parte dei potenti del giorno, i liberi artisti e scienziati siano tenuti a prestarsi reciproca solidarietà e a confortarsi nel pericolo”.
Il testo di quell’opuscolo, stampato nel 1954, nulla ha perso della sua freschezza e attualità. Non è, dunque, solo un documento prezioso dal punto di vista bibliografico; è un testo di “ieri” che vale anche per l’“oggi”; e, si ha ragione di credere (e temere) per domani.
Il comando costituzionale dell’articolo 104 – autonomia e indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere dello Stato – postula la creazione del Consiglio superiore della magistratura, con i compiti stabiliti dall’articolo 105. Ma finora la mancata attuazione di questi comandi costituzionali è stata lamentata e discussa soltanto dall’Associazione nazionale dei magistrati, nei suoi congressi e sul suo organo di stampa: quasi che il problema riguardasse una sola categoria di funzionari ed i loro particolari interessi, e non già la generalità dei cittadini e una loro fondamentale garanzia di vita libera e civile.
Sotto questo secondo aspetto, la questione del Consiglio superiore della magistratura fu proposta alla discussione della Commissione giuridica dell’Associazione italiana per la libertà della cultura da Achille Battaglia nella seduta dell’8 gennaio 1954; ed è dello stesso Battaglia la presente relazione, presentata oralmente al Convegno tra magistrati ed avvocati che si è svolto a Roma, per iniziativa della Associazione nazionale magistrati e del Consiglio dell’ordine, il 15 maggio 1954.
Ai lavori di questo Convegno, che fu presieduto da Federico Comandini, presero parte il giudice Renato Angeloni, segretario generale dell’Associazione nazionale dei magistrati, con una relazione sul problema particolare del P.M. e delle sue guarentigie; e, con interventi di grande rilievo, i senatori Conti e Persico, il vice-presidente della Camera dei deputati Turgetti; il giudice della Corte Costituzionale Battaglini; Panfilo Gentile; il procuratore della Repubblica Ilari; ed altri. Ma anche a questo Convegno parteciparono quasi esclusivamente magistrati.
Noi riteniamo invece che la discussione di un problema importante come questo del Consiglio superiore della magistratura debba uscire dalla ristretta cerchia dei giuristi, ed impegnare l’attenzione dei più vasti settori della pubblica opinione quale fondamentale problema di libertà. Riteniamo perciò opportuno pubblicare la relazione di Achille Battaglia, redatta sulla scorta degli appunti stenografici che furono raccolti al Convegno dei magistrati e avvocati di Roma.
L’articolo 104 della Costituzione garantisce l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario da ogni altro potere dello Stato, da attuarsi per mezzo del Consiglio superiore della magistratura voluto dall’articolo 105. Ma a che scopo questa autonomia e questa indipendenza? Forse a costituire, a favore dei magistrati, prerogative e privilegi incompatibili con l’essenza stessa dello Stato democratico? O per assicurare, invece, alla generalità dei cittadini, quella garanzia fondamentale di libertà che è rappresentata dall’indipendenza del giudice singolo nella decisione delle controversie? Occorrerà fermare su questo punto la nostra attenzione, se vogliamo liberare l’argomento dalla maggior parte degli equivoci e delle prevenzioni recenti.
L’indipendenza dei tribunali fu sempre garanzia di libertà: ma ciò è particolarmente severo – diceva il Tocqueville – nei regimi di democrazia, “ove i singoli cittadini sono troppo deboli per difendersi da sé, e troppo isolati per contare sull’aiuto degli altri”. Ognuno di essi, sciolto dai mille legami che un tempo lo avvincevano e insieme lo difendevano, si è fatto sempre più estraneo al destino degli altri. Su di lui si innalza un potere immenso e tutelare, soffocatore e dolce, che provvede alla sua sicurezza, assicura la soddisfazione dei suoi bisogni, facilita i suoi piaceri, tratta i suoi affari e presiede sempre, arbitro immancabile, alla soluzioni delle controversie private. Ma tollera sempre meno, e impedisce come può, che altri si faccia arbitro delle controversie tra il cittadino ed i propri agenti. Quando il Potere allunga il suo braccio su di noi – per dirla con la frase colorata del De Jouvenel – e spinge i propri agenti a ghermirci nelle nostre case e nei nostri letti, per costringerci a fare o impedirci di fare qualche cosa, è sempre accompagnato da un apparato di costrizione così potente che consente facilmente ogni arbitrio. Si è perciò vanificato, o quasi, quell’istituto della “legittimità della resistenza” che fu già considerato una pietra angolare della civiltà liberale, mentre è divenuta impossibile quella resistenza dei “contropoteri” che caratterizzò lunghi periodi della civiltà europea.
Nello Stato di diritto, la difesa di tutti e di ciascuno, la libertà di tutti e di ciascuno, è soltanto nella legge, e nel giudice chiamato ad applicarla. Ma appunto per questo non esiste, nello Stato moderno, un altro problema di libertà che sia così grave e impegnativo come quello dell’indipendenza dei giudici dal Potere. David Hume, che di libertà si intendeva, è giunto a dire che in Inghilterra tutte le istituzioni hanno questo compito precipuo: “Tutto il nostro sistema politico, e ciascuno degli organi suoi, l’esercito, la flotta, le due Camere, e via dicendo, non sono che mezzi ad un solo fine: la libertà dei dodici grandi giudici di Inghilterra”.
Ma se tutto questo è vero – se il Consiglio superiore della magistratura vuole assicurare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura soltanto per garantire, mediatamente, l’indipendenza del giudice singolo nell’applicazione della legge al caso concreto – è naturale che all’organizzazione di questa fondamentale garanzia di libertà siano addirittura più interessati i garantiti che i garanti: gli avvocati, per esempio, più ancora dei giudici. E consentitemi di ricordare a questo proposito che il primo giurista che parlò in Italia di Consiglio superiore della magistratura (o, quanto meno, il primo ministro che con la legge del 14 luglio 1907 ne realizzò l’organo, contenente in nuce l’attuale) non fu un giudice, ma un avvocato; e, precisamente, l’avvocato che ha presieduto fino a ieri il Consiglio dell’Ordine di questo Foto, e che salì giovanissimo a fama europea proprio per il suo trattato sulla teoria giuridica delle guarentigie della libertà. Al suo nome – al nome di Vittorio Emanuele Orlando – è altresì legata la legge del 24 luglio 1908 sulle guarentigie della magistratura, che costituì un passo decisivo su una via troppo brevemente percorsa. Poi, caddero le guarentigie dei giudici, e gran parte della loro indipendenza, con gli ordinamenti giudiziari del 1923 e del 1941. E quando si teorizzò del cosiddetto “Potere di governo”, come lo chiamò Rocco – e cioè un potere sovrastante a tutti gli altri, e da cui tutti dipendevano – le stesse armi ferirono l’indipendenza del giudice e la libertà del cittadino.
Le paure dei conformisti
Ora, a distanza di appena dieci anni dalla caduta della dittatura, quando si ricordino le fervide discussioni del 1944 e del 1945 su questi argomenti e si confrontino quegli scritti e quei dibattiti con la maggior parte degli attuali, si è costretti a riconoscere che il tono è profondamente mutato. Oggi si preferisce, per prudenza, parlare di “indipendenza” della magistratura piuttosto che della sua “autonomia”, quasi che quest’ultimo termine possa urtare e provocare reazioni. Ma dieci anni or sono non si avevano esitazioni di questo genere; e non solo si parlava senza timidezze di “autonomia” ma si postulava addirittura la sovranità del potere giudiziario. E sebbene si fosse consapevoli dell’errore contenuto in questo termine, concordemente chiarito dai nostri più illustri costituzionalisti, tuttavia lo si usava volentieri, perché si era certi che non avrebbe potuto determinare reazioni.
Ben altro è il linguaggio attuale, e quando l’ascolto mi sento cadere le braccia. Bisogna essere cauti, si dice, bisogna procedere con ogni prudenza. Bisogna stare attenti che la creazione del Consiglio superiore non finisca col creare “uno Stato nello Stato”! Queste parole non le invento io: le ha dette al Senato un ministro di Grazia e Giustizia, e precisamente l’on.Piccioni nel discorso del 24 giugno 1950.
Ma ho inteso ben altro. Che cosa vi proponete di fare – ci si è detto – con questo Consiglio superiore della magistratura, sottratto al controllo di tutti gli altri organi dello Stato? Volete creare la casta chiusa dei magistrati? Volete stabilire un regime di mandarinato? Volete imporre al paese un pauroso salto nel buio? Anche queste parole non sono state inventate da me: sono apparse sui più autorevoli organi di stampa, per esempio sul “Corriere della Sera”.
Che cosa è dunque successo? Abbiamo dimenticata l’epoca in cui le circolari del ministro indicavano ai giudici il modo di decidere le singole controversie? Ci siamo dimenticati, per esempio, della circolare Grandi sui reati annonari, che finiva col vietare ai giudici l’applicazione di un istituto non ancora abrogato dai codici? “Tenete ben fermo – finiva quella circolare – che la sospensione condizionale della pena non deve essere concessa”! Ci siamo forse dimenticati delle ispezioni disposte dal ministro per accertare in che modo ciascun giudice avesse votato nel segreto della camera di consiglio?
Sembra impossibile. Fatti e sistemi di questo genere non possono essere cauti così rapidamente dalla memoria degli italiani! Vediamo, dunque, di renderci conto delle ragioni di questo mutamento di opinione dei ceti politici dominanti, e di accertare se esso denunci veramente un nostro errore, e la necessità di mutare la strada prescelta.
Ragioni del mutamento di opinioni
Innanzi tutto, dobbiamo riconoscere che si sono andati rapidamente esaurendo le nostre capacità e i nostri sforzi di rinnovamento. E’ caduto, in noi, quello spirito risorgimentale con cui, dopo la Resistenza e la Liberazione, avevamo affrontato il grande compito di costruire un nuovo Stato che fosse, finalmente, “lo Stato per gli italiani”. La ragione per cui, a distanza di sei anni dalla sua entrata in vigore, la Costituzione repubblicana è quasi completamente inattuata, consiste proprio in questa caduta delle nostre energie rinnovatrici.
In secondo luogo, dopo il crollo della dittatura, e prima del nuovo assetto costituzionale, si è verificata una resistenza della magistratura alle esigenze sanzionatrici ed epuratrici dei ceti politici dominanti, che è stata giudicata indebita ed esorbitante. E quando, poi, cadde la monarchia e fu creata la Repubblica, sembrò addirittura che la magistratura aderisse malvolentieri al nuovo assetto costituzionale dello Stato. Su fatti di questo genere il nostro giudizio rischia di essere appassionato e affrettato. E’ certo, tuttavia, che un grande numero di italiani non ha ancora dimenticato le esitazioni della Cassazione nella proclamazione dei risultati del referendum, né gli episodi verificatisi alla inaugurazione dell’anno giuridico 1947. Quando il procuratore generale della suprema Corte non credette di dover ricordare, tra i fatti degni di nota dell’anno precedente, il grande fatto giuridico del mutamento costituzionale – e spinse la propria indifferenza fino al punto di non rivolgere un saluto al Capo dello Stato che, per la prima volta, si recava al Palazzo di Giustizia a rendere omaggio alla magistratura (da quella stessa magistratura che altra volta era stata condotta a palazzo Venezia, ad umiliarsi, non al Capo dello Stato, ma al capo del potere esecutivo!) – all’ora l’opinione dei ceti politici che avevano fatto la Repubblica fu messa naturalmente in diffidenza e in allarme.
In terzo luogo, la nostra ripresa liberale e democratica è avvenuta in modo tumultuoso, se non addirittura rivoluzionario, ed è stata naturalmente caratterizzata da clamorosi episodi di esorbitanza e di sconfinamento dei vari poteri. Potrebbero facilmente citarsi più casi in cui la magistratura, sconfinando dal proprio campo, ha cercato di annullare o di eludere decisioni giurisdizionali, ovvero ha preteso sostituirsi ai magistrati con una interpretazione di autorità cui non era affatto legittimato. I due fenomeni, anzi, si sono presentati raramente isolati, quasi che l’uno dipendesse dall’altro: ed in realtà dipendevano entrambi da una sola causa naturale, che non è difficile identificare.
Il legislatore – ha scritto altra volta – tende naturalmente ad innovare. E’ questa, anzi, la sua funzione precipua, per adeguare il diritto codificato con il diritto che si fa. Ma il giudice vuole quasi sempre conservare. “Gli uomini che fecero della legge oggetto dei loro studi – scriveva ancora il Tocqueville – hanno contratto dal loro lavoro una certa abitudine all’ordine, un certo attaccamento alle forme, una certa propensione istintiva alla continuazione generale delle idee che vale a renderli naturalmente avversi ad ogni spirito rivoluzionario. Hanno ideali e costumi aristocratici: e in una società ove occupino il posto elevato che loro si addice, le loro tendenze saranno conservatrici e antidemocratiche”. Nei periodi rivoluzionari, poi, quando la nuova legge urta ed offende di più lo spirito conservatore del giudice, questi più facilmente reagisce, tentando interpretazioni che la modifichino, e che la rendano più simile all’antica; mentre, a sua volta, contro questa esorbitanza del giudice reagisce facilmente il legislatore, ed esorbita, a sua volta, su un terreno che non gli appartiene.
Era dunque naturale che nei primi anni del nuovo assetto costituzionale si verificassero contrasti e conflitti di questo genere; ed era anche naturale che essi aumentassero le diffidenze e moltiplicassero gli allarmi. Ma se ciò spiega il mutato atteggiamento di opinione dei ceti politici della nuova democrazia, non può certo affermarsi che lo giustifichi. I contrasti, i conflitti, le reciproche reazioni tra i vari poteri, durante periodi eccezionali di storia, sono necessariamente legati alla loro tumultuosità, e non possono essere presi a misura dei tempi ordinari.
Ma, soprattutto, episodi di questo genere non modificano i termini essenziali del problema e, a ben guardare, neppure lo scalfiscono.
I veri termini del problema
Si vuole o non si vuole l’indipendenza del giudice nella attuazione della legge e nella decisione delle singole controversie? Se la si vuole, bisogna volere, insieme, l’indipendenza e l’autonomia dell’ordinamento giudiziario. Bisogna consentire, cioè, che le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti dei giudici, le loro promozioni, e le decisioni sui provvedimenti disciplinari che li riguardano, non restino nelle mani del governo o del ministro, ma passino in quelle dello stesso ordine giudiziario. Da lungo tempo, ormai, governanti si sono accorti che per ottenere dai giudici sentenze di favore, non è più necessario imprigionarli o costringerli; basta corromperli. E non esiste un mezzo di corruzione del giudice più efficace di quello che pone nelle mani dei governanti la facoltà di promuoverli e di punirli.
È ben vero che il magistrato, nel momento in cui giudica, è l’organo di una funziona sovrana, e non riceve ordini da nessuno. Ma è anche vero che per esercitare quella funzione egli viene assunto in qualità di impiegato, con un rapporto di lavoro retribuito a stipendio, che aumenta in dipendenza della carriera e delle promozioni.
Quale organo della funzione sovrana – ha ricordato recentemente Piero Calamandrei, – il giudice è svincolato da ogni subordinazione; quale funzionario, è legato al rapporto di impiego e alla disciplina dell’Amministrazione che fa capo al ministro. Se questi “gli fa discretamente intendere che dal modo con cui giudicherà un certo processo può dipendere una promozione o un incarico ambito, o un temuto trasferimento, ecco che, per questa via, nella coscienza del giudice torneranno ad affacciarsi tutti gli stimoli perturbatori di ordine privato ai quali non può rimanere insensibile l’impiegato che pensa al suo stipendio e ai figli da mantenere agli studi”. In questa situazione di cose, l’assoggettamento del giudice al Potere diviene altrettanto completo di quello di ogni altro impiegato. La sua corruzione è meno drammatica, e talvolta non è nemmeno avvertita nelle coscienze che si piegano facilmente al conformismo. Ma il danno di questo facile conformismo, che non rifiuta al Potere le sentenze desiderate, è anche più grave, perché non colpisce un singolo individuo, ma l’intero ordine giudiziario.
Comandi costituzionali inattuati
Contro gli immensi pericoli di una magistratura in tal modo corrotta dal Potere, e ad esso asservita, la Costituzione della Repubblica ha dettato, tra gli altri, i seguenti comandi:
Art.101: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Art.104: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Art.105: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.
Art-107: “I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”.
Sono trascorsi sei anni dalla pubblicazione di questi comandi. Come li abbiamo attuati?
Nel 1947 il presidente della Costituzione affermava che potevano anche concedersi proroghe alla riforma dell’ordinamento giudiziario, ma non poteva farsi altrettanto per la creazione del Consiglio superiore della magistratura, trattandosi di un organo costituzionale che avrebbe caratterizzato il nuovo tipo di Stato voluto dalla Costituente. L’osservazione merita di essere sottolineata. E’ estremamente importante, per esempio, che i magistrati non siano più distinti, tra loro, per il grado gerarchico raggiunto nell’inquadramento burocratico dello Stato, ma lo siano soltanto per le funzioni da ciascuno esercitate: e quando il nuovo ordinamento giudiziario attuerà il comando dell’art.107, i nostri giudici saranno finalmente liberati dalle preoccupazioni della carriera e dal nefasto fenomeno del carrierismo. Ma un nuovo Stato deve, innanzi tutto, costituire i propri organi. Vano sarebbe affermare l’autonomia del potere legislativo se non si provvedesse a creare il Parlamento, e non si togliesse così dalle mani dell’esecutivo il diritto di fare le leggi. Nello stesso modo, è vano collocare la magistratura tra “gli altri poteri dello Stato” se non si provvede a creare l’organo costituzionale che consenta e assicuri la sua autonomia.
Ma proprio questo è ciò che da qualche anno sembra volersi ostacolare. Nel 1949-51 il Centro nazionale d’azione per la riforma giudiziaria (che ebbe presidenti Enrico De Nicola, Vittorio Emanuele Orlando e Meuccio Ruini, per vice presidenti il capo dell’Associazione dei magistrati d’Italia e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, e che fu composto dagli elementi più rappresentativi e competenti del Parlamento, della Magistratura, della Cattedra, del Foro e della Stampa), elaborò un progetto di legge per l’attuazione del Consiglio superiore della magistratura. Ma presentato al ministro Guardasigilli dell’epoca, esso non ebbe l’onore né di essere presentato al Parlamento per la sua discussione, e neppure di essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri per la sua preventiva approvazione.
Nello stesso periodo di tempo un’apposita Commissione ministeriale – nominata con decreto del 24 giugno 1949, presieduta dal Primo presidente della suprema Corte e composta anch’essa di illustri parlamentari e magistrati – elaborò un completo disegno di legge, sia per la riforma dell’ordinamento giudiziario vigente, sia per la creazione del Consiglio superiore. Questo disegno di legge fu accompagnato da una dottissima relazione che esaminava a fondo i problemi relativi allo stato giuridico dei magistrati, alle loro guarentigie, e alla loro disciplina; fu presentato al ministro Grassi, e ne prese addirittura il nome. Ma anche il progetto Grassi non fu sottoposto all’approvazione del Parlamento e, se non erro, non fu neppure delibato dal governo.
La serie degli “insabbiamenti”
Allora un parlamentare, particolarmente sensibile ai problemi della giustizia e della libertà, e che ha sempre combattuto intrepidamente per essi – l’on.Giovanni Conti –, constatato l’insabbiamento dei progetti ufficiali, stralciò dai lavori del Centro giudiziario i pochi articoli riguardanti il Consiglio superiore della magistratura e presentò al Senato un progetto di iniziativa parlamentare che assunse, appunto, il nome i progetto Conti. Ma anch’esso giacque a lungo negli uffici del Senato, e quando il Parlamento fu trascinato nella tremenda contesa sull’ultima legge elettorale, che ha arrecato alla democrazia i danni peggiori, anch’esso si insabbiò.
Intanto, l’Associazione dei magistrati d’Italia intensificava la propria azione per l’attuazione della riforma. Ed ecco che il 24 giugno 1950 si presentò al Senato il Guardasigilli on.Piccioni, e dichiarò che la questione non era ancora matura e si doveva ancora “meditare su di essa”. Fu allora che parlò, come ho già detto, delle cautele necessarie per evitare che il potere giudiziario venisse a costituire “uno Stato nello Stato”. Francamente, non si possono perdonare espressioni di questo genere. Innanzi tutto, non c’è proprio niente da meditare: c’è un comando costituzionale da eseguire. In secondo luogo, sembra che due anni di meditazione sul modo di eseguire un ordine possano essere sufficienti! In terzo luogo, i progetti di legge già noti al ministro non erano stati elaborati da…scavezzacolli. Non c’era pericolo di salti nel buio. Si poteva concedere facilmente – mi sembra – che uomini come Orlando, De Nicola, Ruini, Battaglini, Ferrara, ecc. non fossero acrobati amanti dei salti e, soprattutto, dei salti nel buio. La verità è che sotto il pretesto della necessaria meditazione si nascondeva il desiderio di sottrarsi all’attuazione dei comandi costituzionali.
Nell’anno successivo si svolse il Congresso dei magistrati di Venezia con la vigorosa presa di posizione che tutti ricordano. In segno di protesta contro l’insabbiamento delle riforme, il Consiglio direttivo dell’Associazione dei magistrati d’Italia si dichiarò dimissionario. Allora il ministro Zoli si impegnò formalmente a presentare, prima al governo e poi al Parlamento, un progetto per la creazione del Consiglio superiore della magistratura.
Eravamo giunti, ormai, al primo semestre del 1952; e finalmente i giornali dettero notizia che il Consiglio dei ministri era stato convocato per esaminare due distinti progetti di legge: sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, e sulla costituzione del Consiglio superiore della magistratura. Sul loro contenuto venne conservato il massimo segreto, né gli organi della magistratura o del Foro riuscirono ad avere notizie di sorta, finché non si venne a conoscere che il Consiglio dei ministri, anziché approvare la presentazione dei progetti al Parlamento, aveva nominato una Commissione interministeriale, per esaminarli daccapo.
In verità, si trattava di progetti di legge insufficienti e, a mio avviso, incostituzionali: e poiché è stato possibile, ormai, ottenere su di essi varie indiscrezioni, costerà poca fatica convincersene. Fu anche per questo, probabilmente, che il Comitato interministeriale non condusse a termine i suoi lavori; e con lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni, non si è più parlato della riforma Zoli.
Il disegno di legge annunciato dal ministro De Pietro
Tra i primi e commendevoli propositi manifestati dal nuovo Guardasigilli è la immediata presentazione alle Camere di un nuovo progetto di legge ministeriale sul Consiglio superiore della magistratura. Mancano ancora notizie del suo contenuto sebbene si sussurri, da più parti, che esso costituisca una riesumazione dei progetti Zoli. Ora, non è prematuro l’augurio che questo progetto non venga ancora sottratto al giudizio dei cittadini interessati. In verità, non si riesce a comprendere la ragione di tanto riserbo. Si teme che il giudizio sfavorevole dell’attuale Consiglio superiore della magistratura nominato ai sensi della legge del 1946, o quello del Consiglio nazionale forense – e cioè il giudizio dei due organismi più direttamente interessati alla riforma – possa influire sulle decisioni del Parlamento? Ma, di grazia, perché non dovrebbe influire? Tutti i cittadini, e a maggior ragione i loro organismi di categoria, hanno diritto di interloquire sui problemi che concernono le garanzie costituzionali della libertà. Ma occorre aggiungere che se la riforma dell’ordinamento giudiziario potrà determinare, su norme particolari, contrastanti vedute, un progetto di legge che riguardi soltanto la creazione del Consiglio superiore non dovrebbe dar luogo neppure a discussioni. Esso, infatti, deve limitarsi alla fedele attuazione dei comandi costituzionali, che non sono né vaghi, né incompleti, né di difficile interpretazione, e regolano già, dettagliatamente, l’intera materia. Nessuno pretende di più.
Ma sia ben chiaro: niente di più, ma anche niente di meno di quanto stabilito dalla Costituzione repubblicana. Se mi fosse lecito usare in questa sede la nostra terminologia forense, direi che ciò è imposto da due ragioni, l’una di rito e l’altro di merito:
- a) Innanzi tutto, le norme costituzionali sulla composizione e i compiti del Consiglio superiore, e sui suoi rapporti con gli altri organi dello Stato, debbono essere scrupolosamente osservate perché, se ciò non fosse, il nuovo progetto assumerebbe il carattere di una modifica della Costituzione: e ciò ci farebbe incappare, inesorabilmente, nelle complicazioni dei termini e soprattutto nelle maggioranze richieste dall’art.138, che l’attuale topografia parlamentare non consente di superare.
- b) In secondo luogo, le norme degli articoli 101-110 della Costituzione, esaminate nel merito, appaiono quanto mai caute e prudenti, e tali da superare tutte le preoccupazioni anche negli uomini più timorosi di “salti nel buio”.
I rapporti col Parlamento
Quali sono, infatti, i problemi da affrontare? In sede di disquisizioni giuridiche si potrebbe parlare a lungo dei rapporti tra il potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato. Ma in pratica, interessa soltanto stabilire quali debbono essere i rapporti tra il Consiglio superiore della magistratura e il Parlamento da un lato, e quali debbono essere i rapporti tra lo stesso Consiglio e il ministro della Giustizia dall’altro. Chi vorrà approfondire i due argomenti potrà utilmente rileggere le magnifiche relazioni presentate al Congresso nazionale dei magistrati di Napoli rispettivamente da Gaetano Azzariti e da Emanuele Piga. Ma il primo tema è facilmente esaurito, quando si ricordi che la Costituzione repubblicana assicura i rapporti del Consiglio superiore con il Parlamento attraverso due norme particolari, l’una positiva e l’altra negativa, contenute entrambe nell’art.104. Con la prima di esse di stabilisce che un terzo dei componenti del Consiglio è eletto dal Parlamento in seduta comune e che proprio tra i componenti nominati dal Parlamento deve essere scelto il vicepresidente di esso. Ciò dovrebbe sembrare sufficiente ad eliminare ogni pericolo di “casta chiusa” e di “Stato nello Stato”.
La seconda norma particolare stabilisce: “il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica”. Ciò dice che il Consiglio superiore non può rispondere dinanzi al Parlamento dei propri provvedimenti e delle proprie deliberazioni prese in nome e sotto la presidenza del Capo dello Stato: lo vieta espressamente l’art.90 della Costituzione. Ma, in coscienza, chi potrebbe desiderare diversamente? Chi può desiderare che delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati divenga arbitra una maggioranza parlamentare? Vogliamo dunque togliere dalle mani del ministro e del governo questo potente strumento di corruzione del giudice per affidarlo alla maggioranza del Parlamento: il che significa – per il modo in cui funziona attualmente l’istituto parlamentare – alla segreteria politica del partito di maggioranza?
Ho inteso avanzare una domanda: ma, dunque, il Parlamento non avrà alcun sindacato sull’operato dei magistrati? Bisogna essere espliciti nella risposta.
Se nel regime parlamentare inglese è ancora consentito che le due Camere, e particolarmente quella dei Lords, abbiano il diritto di avanzare esplicite petizioni al Re per la destituzione di un giudice che si sia mostrato inetto nell’adempimento delle sue funzioni, ciò deriva dal fatto che là il sovrano è ancora considerato il distributore della giustizia, e la nomina e le destituzioni del giudice fanno ancora parte delle sue prerogative. Ma già un secolo e mezzo fa un grande parlamentare come il Burke sentiva il bisogno di ammonire il Parlamento a giovarsi assai limitatamente di questo suo diritto, e diceva: “Noi siamo in una situazione molto onorevole per noi, e molto utile per il nostro paese, purché non abusiamo e non violiamo la fiducia in noi riposta”. E con ciò ricordava che in Inghilterra la maggior parte delle nostre questioni sono praticamente superate dal senso del limite e delle responsabilità che sembrano innati nei cittadini non meno che nei governanti di quel paese.
Ma la nostra Costituzione non ha voluto che i giudici vengano nominati dal Capo dello Stato, come diceva l’articolo 69 dello Statuto albertino, e demanda ogni questione concernente il loro stato giuridico al Consiglio superiore della magistratura. Viene dunque a cadere la ragione principale dell’intervento del Parlamento. Ma poiché, come dirò, il ministro della Giustizia ha il potere di promuovere l’azione disciplinare contro i giudici dinanzi allo stesso Consiglio, nulla vieta che, a sua volta, il Parlamento possa sollecitare il ministro all’esercizio di questo suo diritto e chiedergliene conto. Anche qui è questione di limiti e di responsabilità. Di regola, il sindacato sulle sentenze deve esaurirsi in sede giurisdizionale, attraverso i rimedi e le garanzie della impugnazione. Ciò non dice, tuttavia, che l’arbitrio del giudice non possa dare luogo a sanzioni a suo carico: che saranno soltanto di carattere disciplinare, se l’arbitrio non integri più grave violazione (e se ne è avuto recentemente l’esempio proprio in relazione ad una scorretta motivazione di sentenza), ma potranno essere anche di carattere penale quando risultasse violata la legge penale, ed allora la decisione spetterà al magistrato ordinario, con le speciali norme del codice di procedura penale.
Del resto, l’art.101 della Costituzione dice che i giudici sono soggetti alla legge, e non dice affatto che essi le siano superiori. Mi preme anzi ricordare, a questo proposito, un’altra norma costituzionale. Secondo l’art.28, tutti i funzionari dello Stato – e quindi anche i magistrati – sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”. Io sono convinto, e vado da tempo sostenendo, che questa norma costituzionale imponga di rivedere la nostra legislazione, e soprattutto la nostra giurisprudenza, in ordine alla cosiddetta “immunità giudiziaria”: quanto meno, per ciò che riguarda la responsabilità colposa dei giudizi, nelle due ipotesi di negligenza e di inosservanza di legge che abbiano dato luogo alla violazione di una garanzia di libertà del cittadino. E’ questo un tema che esula completamente dal nostro. Ma non posso trattenermi dall’osservare che tanto più facilmente può consentirsi alla assoluta indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato, per quanto più decisamente il giudice singolo sia fatto responsabile di fronte alla legge comune e, almeno entro i limiti sopra indicati, venga mantenuto soggetto all’efficace sindacato dei privati interessi.
I rapporti col Ministro della Giustizia
Ho già detto che il problema di maggior interesse concerne i rapporti tra Consiglio superiore e ministro della Giustizia. Ma, anche qui, la Costituzione dispone in modo tassativo e non c’è che da attuarne i comandi.
Dice l’art.107: “Il ministro ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare”. Essa si svolge, come ho detto, in seno al Consiglio superiore, il quale ne decide. Ma è evidente che il diritto del ministro a promuoverla è già sufficiente ad eliminare la maggior parte delle perplessità di questi ultimi tempi. Si deve anzi aggiungere che questo diritto del ministro non deve essere esclusivo, ma deve essere condiviso da altri organi dello stesso potere giudiziario; il Consiglio superiore, per esempio, o i consigli giudiziari presso le Corti d’Appello o gli altri organi che il nuovo ordinamento vorrà stabilire. Se così non fosse, si consumerebbe un grave attentato proprio contro quell’autonomia della magistratura che si vuole garantire. E ciò non era stato inteso dal progetto di legge Zoli che riservava in esclusiva al ministro il promuovimento dell’azione disciplinare.
Dice poi l’art.110: “Spettano al ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Si racconta, a questo proposito, che un nostro Guardasigilli si sia inteso diminuito dalla norma, ed abbia esclamato: “Io non intendo divenire il ministro delle carceri e delle cancellerie”. Mi sia consentito replicare che la frase è piuttosto sciocca.
Innanzitutto, il diritto di promuovere l’azione disciplinare sui magistrati; quello di segnalare al Consiglio superiore “le esigenze obbiettive della amministrazione della giustizia, avanzando proposte concrete in proposito”; il compito di elaborare (meglio di quanto non si faccia attualmente!) i progetti di legge del dicastero della Giustizia, e quello di portare il contribuito di una specifica competenza alla preparazione dei progetti di legge degli altri dicasteri: tutto questo costituisce un insieme di funzioni e di responsabilità che nessun ministro può considerare al di sotto di sé. In secondo luogo, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi non si esaurisce in questioni di carceri e di cancellerie: e se anche ciò fosse, non sarebbe mai troppo poco. L’attuale Guardasigilli onorevole De Pietro, dimostrando viva sensibilità ai problemi fondamentali del suo dicastero, ha inteso il bisogno di emanare due circolari non appena assunto al governo: la prima di esse riguardava le carceri, la seconda riguardava il funzionamento dei servizi di polizia giudiziaria. Si tratta forse di argomenti così modesti da umiliare il ministro che se ne occupi? Dalla polizia giudiziaria dipende gran parte dell’attuazione della legge penale; dalla migliore organizzazione delle carceri dipende la più alta funzione che possa essere affidata ad un uomo, quella della “rieducazione del condannato” che, ai sensi dell’art.27 della Costituzione, deve ormai considerarsi scopo esclusivo della pena. Chi può, in sua coscienza, ritenersi al di sopra di compiti del genere?
Ad ogni modo, non si può andare più oltre. Se al ministro della Giustizia – e cioè ad un organo che più volte, durante i lavori della Costituente, si progettò di sopprimere – si attribuissero altri poteri sui magistrati, non si obbedirebbe alla volontà costituzionale proprio per questo. Oltre a riservare in esclusiva al ministro l’azione disciplinare, quel progetto disponeva che tutti i provvedimenti del Consiglio superiore dovessero essere presi “su proposta” ovvero “su richiesta” del ministro; e aggiungeva, infine, che il Consiglio superiore “ha sempre l’obbligo di sentire il ministro prima di deliberare”. Nossignore! Queste disposizioni contrastano con la volontà della Costituzione, la quale escluse ogni partecipazione del ministro ai lavori del Consiglio superiore, anche quale organo consultivo. Impedendo poi, ogni iniziativa autonoma dello stesso Consiglio, eludono e rendono vane le stesse ragioni a cui esso è ordinato.
Speriamo che il progetto De Pietro non segua, su questa materia, le orme del progetto Zoli. Esso non giungerebbe in porto, non tanto per le giuste resistenze della Curia e del Foro, quanto perché sarebbe un progetto di modifica costituzionale. E, a prescindere dalla questione delle maggioranze, tutti dobbiamo sentire il dovere di cominciare ad attuare la Costituzione prima di modificarla, e non possiamo tollerare che essa sia modificata prima ancora che venga attuata.
Le elezioni del Consiglio superiore
Mi sia consentita una parola anche su questo ultimo argomento, la cui importanza non sfugge a nessuno, ma a cui sono particolarmente sensibili gli stessi magistrati.
Al Consiglio superiore partecipano di diritto: a) il Presidente della Repubblica che lo presiede; b) il Primo presidente della Corte di Cassazione; c) il Procuratore generale della stessa. Gli altri componenti, dice l’art.104, sono eletti: per un terzo del Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari e avvocati, e “per due terzi da tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie”. Tutti i componenti del Consiglio appartenenti alla magistratura dunque, che non ne facciano parte di diritto, debbono essere sempre eletti da tutti i magistrati delle varie categorie. Non potranno compiersi elezioni separate per ciascuna categoria. Si tratti di elezioni di primo o di secondo grado, il collegio elettorale deve essere unico, e la lista definitiva dei candidati deve essere unica.
Ora, tanto il progetto di legge elaborato dalla Riforma giudiziaria, quanto quello elaborato dalla Commissione ministeriale Grassi, erano rispettosi di questo principio; e, tuttavia, volendo contemperare il comando costituzionale con l’esigenza di favorire la scelta dei migliori, avevano escogitato un sistema di doppia votazione che meriterà di essere segnalato. Ma non era stato altrettanto osservante del principio il progetto Zoli, che, secondo le indiscrezioni divulgate, prevedeva collegi elettorali diversi ed elezioni per categorie, con predominio notevole della categoria dei magistrati di Cassazione.
Nel sistema della doppia votazione, la prima di esse non serve che a designare i candidati, in numero triplo o doppio a quello degli eleggibili. La designazione si effettua nell’ambito dei collegi circoscrizionali; i magistrati di Cassazione costituiscono un collegio a parte; ciascun elettore vota per un numero di magistrati pari a due terzi dei candidati da designare: e, in tal modo, viene costituita una lista che comprende le rappresentanze di tutte le categorie, con adeguato rispetto delle minoranze. Su questa linea, poi, i magistrati costituiti in collegio unico nazionale procedono alla elezione dei componenti del Consiglio, rispettando il numero delle rappresentanze riservate in ogni categoria.
Ma, innanzitutto, chi sono i “magistrati ordinari” che hanno diritto di eleggere e di essere eletti?
Ordine giudiziario e “ministeriali”
La questione è stata proposta e risolta dal Centro giudiziario con questa osservazione: che siccome la garanzia costituzionale di indipendenza dell’ordine è diretta soltanto a garantire la indipendenza delle funzioni effettivamente esercitate, l’ordine giudiziario deve considerarsi composto dei soli magistrati ordinari in attività di funzioni giudicanti o requirenti. Da questa definizione derivano due importanti conseguenze:
1) Fanno parte dell’ordine giudiziario, e sono quindi elettori ed eleggibili al Consiglio superiore, tutti i funzionari del PM in attività di funzioni requirenti.
2) Non fanno parte dell’ordine giudiziario i magistrati applicati ai ministeri, o ad altri uffici amministrativi, anche se non siano posti fuori ruolo.
Ritengo opportuno far notare che il progetto Zoli non solo non concordava in questa necessità di escludere i “ministeriali” dal Consiglio superiore, ma anzi faceva obbligo di eleggere un buon numero di essi, istituendo un apposito collegio loro riserbato! La proposta è chiaramente inaccettabile. L’intervento dei ministeriali nel Consiglio superiore può rappresentare addirittura il cavallo di Troia della sua indipendenza. Ma, a prescindere da ciò, è bene dire qualcosa su questa applicazione di giudici a funzioni meramente amministrative. Per l’ampiezza con cui si sta verificando, essa è ormai divenuta abusiva e illegale anche nei confronti dell’ordinamento giudiziario fascista del 1941. La prassi non può essere continuata. In generale, questi giudici vengono posti fuori ruolo; ma, data la loro vicinanza al Potere, essi si avvantaggiavano facilmente nella carriera, di fronte ai meno fortunati colleghi che continuano ad amministrare la giustizia. Ed ecco che, dopo parecchi anni trascorsi nell’espletamento di pratiche amministrative che non hanno mai impegnato la loro coscienza nella terribile responsabilità della sentenza, li vediamo spesso comparire sui più alti seggi giurisdizionali, cui non possono portare che le loro abitudini di burocrati distaccati dalla routine. E’ questo un abuso che deve cessare. Se qualche magistrato preferisce alla funzione del giudice quella del burocrate, non v’è ragione per cui debba continuare a far parte dell’organico dell’ordine giudiziario e non venga assunto in quelli dell’amministrazione, in modo da ottenerne i vantaggi e gli svantaggi relativi.
Anche qui un comando costituzionale chiede di abolire le promozioni, secondo il sistema inglese, e di liberare il giudice da tutte le preoccupazioni della carriera. E soltanto quando il magistrato sarà liberato da questa preoccupazione – che diviene assillante nel periodo degli scrutini – sarà assicurato al paese un giudice veramente indipendente. Con il Consiglio superiore lo avremo sottratto alla soggezione e all’ossequio verso il ministro: ma non avremo ancora eliminata la sua soggezione verso i superiori gerarchici destinati a vagliare i suoi titoli alla promozione. Da ciò nasce facilmente quel conformismo di classe che è più grave nei magistrati che in ogni altra categoria di funzionari.
A mio avviso, il maggior pericolo che ci minacci è quello che i nostri magistrati divengano sempre più burocrati e sempre meno giudici. Liberandoli da ogni preoccupazione di carriera, li libereremo da ogni stimolo al conformismo; anche al conformismo giuridico. E ciò che sarà perduto nella uniformità dell’interpretazione della legge, sarà guadagnato dal giudice in equità, cioè in quel suo potere di decidere, con liberale apprezzamento delle circostanze del caso, che nobilita ed eleva la funzione di applicazione della norme astratta al caso concreto appunto perché la rende meno meccanica, meno automatica, meno scientifica – se si vuole – ma più umana e più responsabile.