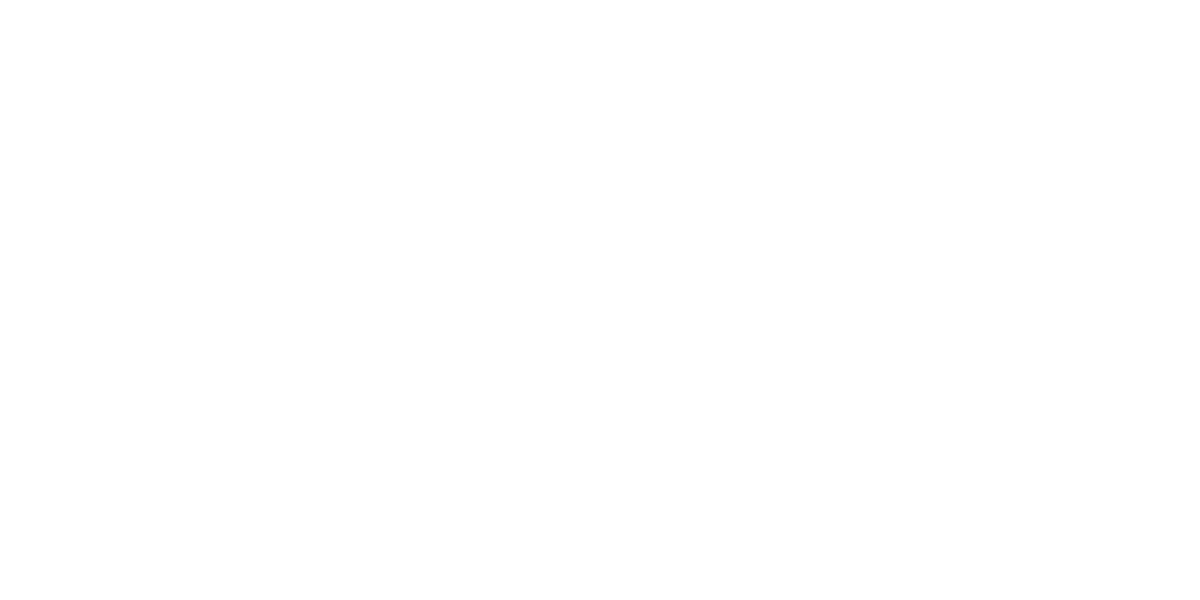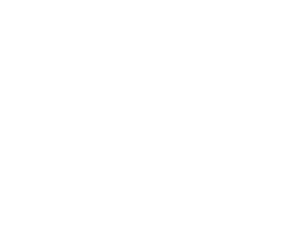Il docente di filosofia teoretica e di filosofia morale: “A chi mi chiede se ci credo, rispondo che non sono fatti suoi. Dopo Kant Dio non è più un problema della ragione. Dovremmo incominciare a viaggiare più leggeri”
La prima cosa che Aldo Masullo dice – alla tenera età di 93 anni che compirà martedì – è di sentirsi un istrione. La maschera del filosofo che pare ereditata dagli ozi campani dell’antica Roma è avvolta da una diafana incorruttibilità. Usa la parola “istrione” con la stessa disinvoltura con cui direbbe “buono” o “interessante” o magari “perfido”. Nell’antica Roma l’istrione era l’attore. Col tempo, si sa, è prevalsa la platealità del mestiere. Petrolini che recitava Nerone era istrione e piacione. Istrione, sommo, fu Carmelo Bene e anche Gassman, il mattatore. Su versante letterario istrione fu D’Annunzio con la sua impresa di Fiume. Masullo è un po’ filosofo e un po’ mattatore; gli piace piacere. Sedurre con la parola. Dal quartiere Vomero dove vive da quasi cinquant’anni – la Napoli degli abbienti, quella perlopiù ignorata dal teatro popolare – si alza un sottofondo di umori commerciali e di traffici collinari. “Qui, a poca distanza, Eduardo Scarpetta si fece costruire un palazzetto in Liberty napoletano: “Villa la Santarella” che poi di santo aveva poco. Ci confinò la moglie e ci scrisse pure una bella frase “Qui rido io””.
Il riso è importante in filosofia?
“Lo è, come ci ha insegnato Bergson. Ma ancora più importante è il gioco. Qualunque cosa si faccia ha alla sua base il gioco simbolico. Lo appresi da Eugen Fink, negli anni in cui studiai a Friburgo. Ai suoi occhi il gioco era l’immagine stessa del mondo, il modello del Tutto. Fink non aveva fatto altro che mettersi nelle mani di un celebre passo di Eraclito: “Il tempo è un fanciullo che gioca a dadi col mondo”. Ne diede una traduzione un po’ diversa, ma il senso era che costruire e distruggere hanno in sé il tratto dell’assoluto e anche dell’innocenza”.
Fu un aspetto che incuriosì Nietzsche.
“Al punto da farne uno dei pilastri della sua visione del mondo. Tutto lo stile nicciano, al di là di ogni trattazione seria, richiama il giocoso, il bisogno di “giocare con la filosofia” “.
Il filosofo è una sintesi tra l’artista e il fanciullo.
“Esattamente. Così come l’uomo è di volta in volta giocattolo e giocatore”.
Ha mai pensato che siamo nella patria del gioco?
“Intende Napoli?”
Una risposta al fanciullo che gioca a dadi è l’adulto che gioca al lotto.
“Il gioco del lotto è l’enciclopedia del modo in cui il napoletano vive se stesso. Per secoli siamo stati un popolo sottoposto alla dominazione straniera; incapace di riscattarsi e di raggiungere traguardi più degni. Per il napoletano che non accede al regno degli eroi e dei potenti, il lotto è il solo spazio nel quale potersi rifugiare. È destino, caso, fortuna, speranza e trascendenza”.
Il suo destino come se lo era immaginato?
“Fuori dalla rassegnazione. Sono nato ad Avellino e con i miei ci trasferimmo a Torino. Mio padre impiegato alle ferrovie. Si pensionò in anticipo e tornammo al Sud, nel 1939. Precisamente a Nola. Scelsero Nola non perché fosse la patria di Giordano Bruno, ma perché c’era un ramo della famiglia, composto da piccoli industriali del vetro”.
Di lì a poco sarebbe scoppiata la guerra.
“Appresi la notizia mentre svolgevo il compito di italiano per la maturità classica. Immaginai la guerra come uno scontro epico, dove tutto si sarebbe rigenerato. Il suo volto terribile lo scoprii in seguito. Ho vissuto le privazioni. Ho visto la ritirata dei tedeschi. Ho assistito all’eccidio di Nola”.
Se ne sa poco.
“Fu cruento e coinvolse una guarnigione di militari che resistette alla divisione corazzata “Hermann Göring”. La superiorità tedesca ebbe la meglio. Per rappresaglia furono fucilati dieci ufficiali italiani. Tra questi c’era un tenente, Enrico Forzati, che si offrì al posto di un altro ufficiale. Motivò quel sacrificio così: tu hai figli e moglie, io sono solo. La mia morte non provocherà altre morti”.
Che anno era?
“Era settembre del 1943. L’anno dopo presi la prima laurea, in filosofia. Ma non ero certo che avrei fatto il filosofo”.
Cosa lo impediva?
“Avevo iniziato a fare pratica nello studio di un avvocato. Ero attratto dalle dinamiche del processo penale. Mi iscrissi perciò a Giurisprudenza e presi la seconda laurea nel 1947. In quegli anni conobbi Alfredo De Marsico, il grande penalista le cui arringhe a braccio incantavano l’uditorio. Questo monarchico liberale poteva parlare per ore, senza un’incertezza, una sbavatura”.
Un modello di istrionismo.
“Incarnava la grande tradizione giuridica meridionale. La sua abilità retorica ricordava l’oratoria di Demostene”.
In tarda età difese, con la sua oratoria, uno degli imputati del delitto del Circeo.
“Aveva più di novant’anni quando difese Angelo Izzo, avrebbe fatto meglio a godersi la pensione. Le arringhe sono tecniche di persuasione. Prescindono dall’aspetto etico. Diventano sfide: parole lanciate per sedurre”. A volte per confondere. “Indubbiamente. Fu Platone che condannò la sofistica”.
Alla fine perché abbandonò il mondo della giurisprudenza?
“Divenni assistente ordinario. Mi ero laureato su Julien Benda, con una tesi discussa con Emilia Nobile, crociana e studiosa dei mistici tedeschi”.
Benda era famoso per il libello sul “Tradimento dei chierici”.
“Tema a quanto pare ancora oggi attuale”.
In quegli anni Croce era la più alta autorità filosofica.
“Il culto di Croce fu un fenomeno che si sviluppò nel dopoguerra. Ricordo quest’uomo dall’aria bonaria che andai a trovare a Palazzo Filomarino. Mi ricevette un po’ distrattamente. Mi disse occupati della storia, la storia è la sola cosa che non morirà mai. C’era come un cerchio magico intorno a lui. Persone che lo proteggevano: i crociani”.
Lei non era crociano?
“Mai stato. Allora le mie tendenze – dopo le letture di Boutroux, Blondel, Bergson – erano spiritualiste. E poi c’era il marxismo che cominciava a far presa nel mondo napoletano. Mi trasferii a Napoli nel 1950. Una città che ribolliva di iniziative culturali. A parte l’interesse per Marx – di cui si fecero fautori Napolitano, Amendola e lo stesso Alicata – c’era la Società filosofica che a Napoli era coordinata da Cleto Carbonara, un uomo di notevole ingegno teorico che tentò di ibridare Gentile e Croce, correggendone i formalismi astratti con un’apertura all’empirismo”.
Lei era all’università?
“Sì, come assistente ordinario. In quel periodo alla cattedra di teoretica fu chiamato Paolo Filiasi Carcano, allievo di Antonio Aliotta. Paolo era una personalità complessa. Studioso di matematica, interessato alla psicoanalisi. Fu lui a introdurre all’università di Napoli la fenomenologia di Husserl”.
Accennava al suo periodo in Germania.
“Fu dopo che conseguii la libera docenza, nel 1957, che ottenni una borsa di studio per Friburgo. Vi avevano insegnato prima Husserl e poi Heidegger. Ci insegnava ancora l’ultimo allievo di Husserl: Eugen Fink. Era un uomo simpaticissimo. Un grande seduttore. Non so quale demoniaca inclinazione possedesse, ma aveva la capacità di inchiodarti con le parole e lo sguardo. Le sue riflessioni filosofiche sugli aspetti simbolici del gioco sono state fondamentali”.
Che Germania aveva sotto gli occhi?
“Un paese che stentava a rinascere dopo la sconfitta. La società civile non aveva ancora assorbito il trauma della guerra. Meglio andava la società culturale che oscillava tra la grande tradizione goethiana e il rinnovamento letterario, in particolare promosso dal “Gruppo 47″. Noi italiani, sparsi nelle università, eravamo interessati alla loro filologia e alla filosofia. Perfino a Nietzsche, considerato in quegli anni un autore pericoloso. Ricordo certe sere in cui Ferruccio Masini, che sarebbe diventato un eccellente germanista, mi leggeva in tedesco Così parlò Zarathustra”.
Un libro per tutti e per nessuno, come recitava il sottotitolo.
“Un poema vertiginoso, beffardo, profetico. Dove tutta la modernità è chiamata al cospetto di quest’uomo che l’accusa degli scempi peggiori. E lo fa con la tranquillità di chi descrive qualcosa di ineluttabile. No, non è un libro per tutti, come scrisse ironicamente. È un libro per coloro che amano tramontare”.
Che cosa è per lei il tramonto? Condizione nella quale mi pare versiamo ampiamente.
“Tramontiamo da sempre come da sempre il nichilismo pervade l’Occidente. Fu Eraclito a ricordarci che di ogni ente mortale non si può disporre due volte. E che la cosa mentre è non è. Contro il nichilismo si sono costruite macchine ideologiche e religiose oggi inutilizzabili. Anche perché è mutato il senso che noi attribuiamo al nichilismo”.
Viviamo in un’epoca nichilista?
“Vi siamo pienamente immersi. Ma con questa differenza rispetto al passato: oggi non è più interessante il nichilismo teorico, quello che affermava, da Nietzsche a Dostoevskij, che siccome non c’è più verità allora tutto è possibile. Oggi la gente ha rovesciato questa sentenza e dice che siccome tutto è possibile allora non c’è più verità”.
Con quali conseguenze?
“Che al nichilismo non ci si oppone con la filosofia, con la teoria. Il problema è diventato politico. E purtroppo la politica non nasce astrattamente. Non può essere un gesto di buona volontà. Occorre un processo storico che tenga conto delle nostre vite concrete. Del punto in cui si collocano”.
Dove esattamente?
“Il nostro tempo storico ci mostra qualcosa di paradossale: nel massimo della connessione informatica, l’uomo sta vivendo il massimo della sconnessione civile. Il compito della politica – al di là delle esigenze amministrative – dovrebbe essere quello di ricreare una tensione verso l’unità, la connessione appunto. Non virtuale, ma dei corpi. Ma ho paura di parlare invano”.
Paura perché?
“Ho l’impressione che stiamo vivendo ciò che io chiamo la “razionalità idiota”. Idiota non tanto delle scarse capacità intellettive, ma come suggerivano i greci dell’attenzione dedicata al proprio particolare. Siamo come i topi di una nave che affonda, ciascuno cerca la sua via di salvezza. Ma non è così che ci si salva”.
In quale modo, allora?
“Una delle chiavi della modernità civile è il rispetto. Che non vuol dire devozione, ma consapevolezza della relazione. Tutto ciò che io penso ha un senso solo se si confronta con quello che pensano gli altri. Il rispetto significa non interferire con la vita mentale dell’altro, ma confrontarsi con essa”.
Il che non impedisce incertezze, equivoci, prevaricazioni.
“Tutto questo rientra nel sentire della vita. Ho elaborato in modo diverso la categoria della paticità. Il pathos non significa, come comunemente era stato inteso dopo le deformazioni romantiche, soffrire. Pathos è provare. Provare la vita”. E Dio? “A chi mi chiede se ci credo, rispondo che non sono fatti suoi. Dopo Kant Dio non è più un problema della filosofia”.
Lei dice “provare la vita”, tutti la provano, meglio ci sono immersi.
“Ciò che intendo dire è che la mia vita appartiene a una realtà sempre in movimento. Non posso esiliarmi da essa. Ma devo comprendere come starci. Siamo semplici particelle di energia, secondo la visione democritea, che si muovono a caso o esprimiamo un’energia vitale e unitaria come pensarono gli stoici e in seguito Giordano Bruno?”
Che risposta dà?
“Oggi viviamo più la prima. Ma dovremmo richiamarci a quel maestro di anarchia che è stato Giordano Bruno, per il quale l’unica conversione possibile era alla giustizia”.
Si sente un uomo realizzato?
“Non lo sono. Più vado avanti negli anni e più o la sensazione di aver perduto tempo. Un tempo ormai irrecuperabile. Le confesso però che non mi pento di nessuna delle cose che ho fatto, mentre mi pento per tutto quello che non ho fatto”.
Ancora una punta di istrionismo.
“Torniamo alla teatralità e al gioco”.
Torniamo a una certa idea di Napoli.
“Questa città è solo rappresentazione. Ci innamoriamo del nostro apparire belli e singolari agli occhi del mondo. Una forma di narcisismo che spinge una società urbana alla propria decadenza. Ma non possiamo vivere di solo fascino. Perfino la malinconia napoletana è diventata qualcosa di pittoresco”.
Forse di necessario.
“Chi lo sa. In un verso Empedocle dice: “La grazia odia l’intollerabile necessità”. Il nostro popolo non ha mai amato la necessità. Semmai l’ha vissuta, o aggirata con estro e fantasia. Ma oggi queste ultime sono armi inservibili. Oggi bisogna ritrovare la nostra destinazione che non è la morte, che pure arriverà e in me non è lontana, ma la vita. L’umanità sta uscendo sconfitta dal troppo. C’è troppo di tutto. Almeno qui, in Occidente. Cominciamo a viaggiare più leggeri”.
Fonte: Repubblica.it